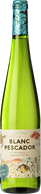| Tipo | Confezione |
|---|---|
| Allergeni | Contiene solfiti |
Vini vulcanici: il Veneto

Questa esclusiva confezione è abbinata a una degustazione in streaming video che Italvinus organizza venerdì 9 luglio 2021 alle 18:00. Sarà possibile collegarsi allo streaming accedendo semplicemente alla nostra pagina Facebook. La confezione comprende, rispettivamente, una bottiglia del Lessini Durello Pas Dosé 2015, spumante a metodo classico dell'azienda Fongaro di Roncà (VR), del Soave Classico Monte Carbonare 2018 dell'azienda Suavia di Fittà di Soave (VR) e del Colli Euganei Rosso Covolo 2017 dell'azienda Vignale di Cecilia di Baone (PD).
Vino e vulcano: un rapporto ancestrale
Il rapporto vulcano/vite è uno dei più ancestrali ed affascinanti della storia della viticoltura ed ancora oggi genera prodotti inimitabili, mai scontati, uniti da una salinità inconsueta, che evolve in decisa mineralità nel tempo. I distretti vulcanici hanno genesi eterogenee che si riflettono in suoli differenti per struttura fisica, acidità e composizione chimica; comune denominatore, l'abbondanza di elementi minerali.
Vigneti storici, spesso a piede franco, impiantati nei secoli e sopravvissuti alla fillossera, ma anche terrazzamenti ancestrali, che fino ad altitudini considerevoli, anche superiori ai 600 metri, regalano la soddisfazione di degustare calici meravigliosamente eroici. Terre difficili, polverose, nere, compatte, pericolose e quindi evocative. La costante? Una mineralità schietta, decisa, con un nerbo di freschezza e verticalità dominante e impetuoso, sia nei bianchi, di beva eccellente e molto eleganti, sia nei rossi, austeri, taglienti. Erbe aromatiche, zolfo, sali, pietra focaia sono solo alcuni dei sentori che, tra realtà ed evocazione sensoriale, caratterizzano le migliori etichette vulcaniche italiane.
A molti risultano evidenti le connessioni tra terroir vulcanico ed esame organolettico del vino. Certamente, appare tuttavia più prudente parlare di “vini da suoli vulcanici” piuttosto che di “vini vulcanici”. Perché? Perché dal punto di vista strettamente scientifico il collegamento suolo-vino è ancora da dimostrare, o perlomeno da perfezionare. Lo storytelling del vino vulcanico, che chiama in causa sentimenti contrastanti come la paura della terra aspra, della casa degli dei che alimenta ma al tempo stesso trema, distrugge, irrompe, è sicuramente affascinante.
Il vulcano evoca immediatamente un’idea di vino difficile, eroico, titanico, complesso, atavico. Ma anche i vini che possono a pieno titolo fregiarsi di questa “vulcanicità” sono, nel loro profilo sensoriale, condizionati da molti altri fattori, che differiscono a seconda del clima, dell’altitudine, dell’esposizione, del sistema di allevamento, della densità d’impianto e di tutte quelle opzioni determinate dallo stile produttivo dell’azienda.
Alcune note tipiche, in teoria, dei vini vulcanici, come quelle di affumicate o di pietra focaia, pur riconducibili idealmente ai suoli per ovvi motivi, sono talvolta la conseguenza di affinamenti in legno. In più, conta anche il profilo sensoriale primario delle uve: alcune, come il riesling, manifestano note minerali e di polvere da sparo anche se non allevate su suoli vulcanici. Suoli che, a detta di molti, conferiscono infatti una più percepibile complessità olfattiva ai vitigni cosiddetti “neutri”, cioè non caratterizzati da una aromaticità definita, proprio come moltissime uve bianche autoctone italiane, tipiche, piuttosto, per verticalità, acidità, sapidità (ad esempio la garganega).
Le caratteristiche dei suoli
I produttori di vini vulcanici italiani avvertono quindi l’esigenza di accompagnare l’agile marketing del territorio con un adeguato approfondimento scientifico, fatto di zonazioni, mappature, sondaggi dei suoli. Questo anche perché coltivare la vite su questi suoli comporta naturalmente l’esclusione di qualsiasi mezzo meccanico e la riduzione cospicua delle rese.
Tra i fattori che determinano questa situazione, sussistono ovviamente le pendenze spesso estreme, i sistemi di allevamento sovente molto antichi, come gli alberelli, che impediscono l’accesso alla vigna se non manualmente, e non ultima la natura particolarmente aspra e difficile dei terreni, che costringono le radici delle viti a un duro lavoro di penetrazione nei suoli: poco frutto, quindi, ma molto concentrato ed equilibrato, non di rado da vecchi ceppi, talvolta centenari, a piede franco, cioè immuni dalla fillossera, il parassita della vite che non sopporta le condizioni estreme dei comprensori vulcanici.
In Italia si possono contare circa 17000 ettari vitati su terreni vulcanici. Ma questi 17000 ettari insistono in realtà su suoli molto differenti tra loro. Anzitutto bisogna distinguere vulcani attivi (come l’Etna, le Eolie, i Campi Flegrei), quiescenti (come il Vesuvio) e spenti (come il Vulture). Solo i primi riforniscono continuamente il territorio circostante di particelle minerali e nutrienti, ottime per la viticoltura e perché inglobano aerosol e si sedimentano al suolo anche in modo non impetuoso. Negli altri comprensori, la vite beneficia invece di sedimenti antichi, a volte antichissimi e a stento riconoscibili come vulcanici, ad esempio quando i coni sono stati abbondantemente erosi da venti e correnti oppure sostituiti da laghi.
I suoli vulcanici possono quindi presentarsi in modo assai vario. Ce ne sono di più compatti, rassodati in tufi, basalti o graniti. E ce ne sono di più sciolti, polverizzati in ossidi, sodio, silice, potassio, magnesio, ferro, fosfati. Insomma, tutte sostanze minerali potenzialmente in grado di conferire al vino salinità e sapidità. Naturalmente, le formazioni vulcaniche più recenti non sono idonee alla coltura: ci vogliono infatti 500-600 anni dopo la colata prima che in quello stesso luogo si possa rigenerare l’allevamento della vite. Ma il denominatore comune di queste formazioni è la macroporosità: le rocce vulcaniche sono ricche di grossi pori capaci di immagazzinare risorse idriche per il 100% della loro massa, garantendo alle piante una riserva consistente anche per le stagioni aride.
Il Soave
C’è, ma non si vede. Eppure si sente, eccome, nel calice. Può riassumersi in questo modo la presenza, in Veneto, del suolo vulcanico. Già, perché a parte poche eccezioni relativamente visibili ad occhio nudo, il terroir vulcanico veneto è di formazione antica, e appare, a uno sguardo sommario, perfettamente integrato nel paesaggio. Ciò nonostante, quattro importanti denominazioni geografiche venete sono interessate dalla presenza di suoli vulcanici, e sono grossomodo raggruppabili in due zone accomunate da un clima continentale, mediamente piovoso ma complessivamente temperato: la prima è il grande comprensorio del Soave, del Gambellara e dei Monti Lessini, tra le province di Verona e Vicenza, e la seconda è la regione storica dei Colli Euganei, nel Padovano.
Una regione che distribuisce il 20% del vino di qualità italiano, e che lo fa partendo spesso ancora da tecniche di allevamento tipiche, come la pergola e il tendone, pur accostate sempre di più alle moderne spalliere. Regione vocata, com’è noto, all’assemblaggio di diverse uve tipiche dei territori, dopo la fillossera ha ricorso ampiamente ai vitigni internazionali nella sua parte orientale, mentre è tornata prevalentemente ad affidarsi all’autoctono nelle province occidentali.
Storia – Il Soave, che oggi conta circa 6500 ettari distribuiti tra circa 3000 produttori e viticoltori, non ha bisogno di molte presentazioni: costituisce, senza ombra di dubbio, una delle massime espressioni del vino bianco italiano. Ogni sua zona, quasi ogni collina della denominazione, vocata alla grande viticoltura fin dall'alto Medioevo (un primo “disciplinare” risale persino allo Statuto Ezzeliniano del 1228), possiede un carattere particolare, che confluisce nella straordinaria specificità della zona classica, tra Soave, Monteforte d'Alpone e Brognoligo. Qui, ad un'altitudine che oscilla tra i 40 e i 400 metri s.l.m., si trovano anche i ceppi più antichi della denominazione.
Oggi il Soave è il primo sito vitivinicolo in Italia riconosciuto dalla FAO come Patrimonio Agricolo di Rilevanza Mondiale. Ma la sua storia è molto lunga. Ai tempi dei Romani, il Soave, insieme alla Valpolicella ai vini del Veronese in generale, può essere considerato tra i vini che allora si definivano “retici”: vini amatissimi negli ambienti patrizi e persino imperiali, ma che non sono del tutto riconducibili a quelli attuali. Solo a partire dal Medioevo le fonti iniziano a documentare la produzione di vino nel contesto specifico di Soave e del suo contado, intorno allo splendido castello scaligero che ancora oggi è possibile ammirare. Un’incisione latina del 1375 sulla facciata del tribunale descrive ad esempio i tempi in cui le persone pressavano l’uva con i piedi a Soave.
Da lì in poi, le testimonianze si infittiscono. Nel 1438, il doge inviò Marin Sanudo, esperto di vino veneziano della corte, a visitare i vigneti e le fortificazioni di Verona. Sanudo descrisse Soave come una “suavissima piacevole terra, ricca di buoni vini”. L’Ottocento è il secolo della codificazione del Soave: nel 1816, nell’ambito del registro civile napoleonico, compaiono per la prima volta documentati i nomi e i confini dei vigneti storici dell’attuale denominazione, e nel 1873, ad opera di Giovanni del Sie, si definiscono finalmente le caratteristiche pedologiche (i suoli) e organolettiche del comprensorio e del suo vino.
Vino amato dal forse astemio d’Annunzio (“vino della giovinezza e dell'amore. Lo bevo in omaggio al passato: se non mi ridà i miei vent'anni, me ne ravviva il ricordo”), il Soave supera brillantemente la fillossera, reimpiantando rapidamente il patrimonio vitato perduto, e, in seguito alla fondazione del consorzio di tutela nel 1924, acquisisce già nel 1931 il titolo di “zona vinicola ufficiale”, prima volta per un bianco italiano. I confini dell’areale, da allora immutato, diventano DOC nel 1968. Oggi il Soave è anche alla guida di un movimento di valorizzazione e comunicazione dei vini vulcanici del mondo, chiamato Volcanic Wines.
Disciplinare – Il Soave è tutelato da una DOC che, come è ben noto, ne disciplina la produzione con uvaggio minimo del 70% di garganega; il residuo è generalmente destinato al trebbiano di Soave, ma sono consentiti anche altri vitigni, come lo chardonnay. Molti produttori si sono orientati alla produzione del Soave da garganega in purezza, per valorizzare l’uva giustamente considerata più legata al territorio. La menzione “classico” spetta ai Soave che derivano dai vigneti storici dei comuni di Soave e Monteforte d’Alpone; la DOC può essere rivendicata anche per gli spumanti, considerato che la garganega, uva naturalmente ricca di acidi e minerali, ben si presta a questa tipologia.
Esiste da una ventina d’anni anche la DOCG Soave Superiore, che insiste sullo stesso areale della DOC ma richiede un affinamento minimo del vino in cantina di cinque mesi e, teoricamente, la tipologia “riserva”. Teoricamente perché, a conti fatti, pochissime aziende rivendicano la DOCG e, pur rispettando standard qualitativi ben più rigorosi, preferiscono imbottigliare i loro grandi vini con la DOC tradizionale. Quanto all’affinamento, la garganega si presta ottimamente pronta, da solo acciaio, ma anche con alle spalle un affinamento – e in alcuni casi una vinificazione – in legno; beneficia, naturalmente, di una sosta sur lie in qualsiasi recipiente.
Nella stessa regione si produce anche il celebre Recioto di Soave DOCG, forse il frutto più nobile della garganega. Vino di antica tradizione, prende il nome dalle “recie”, cioè la parte più alta del grappolo, meglio aerata ed esposta al sole, naturalmente più ricca di zuccheri ed estratto. La garganega destinata al Recioto, una volta selezionata, viene posta su graticci (ma talora anche appesa) in genere in locali idonei e ben aerati (occasionalmente anche all'esterno), dove rimane spesso fino a Natale e dove, a volte, viene arricchita da un lieve strato di muffa nobile. Pigiata e vinificata con lentissima fermentazione che può avvenire a varie riprese, l’uva diventa un vino destinato a un lungo affinamento in botti di rovere. Un vino dolce che riceve dal terroir vulcanico e dal clima frizzantino una notevole spalla acida e una piacevolissima spinta minerale.
Le uve e i sistemi di allevamento – La garganega, pur non caratterizzata da una aromaticità spiccata – è, infatti, tra le uve “neutre” che valorizzano al massimo le potenzialità del suolo vulcanico – possiede un ventaglio di profumi che oscilla con decisione e grande eleganza dal fiore bianco alla mandorla, talvolta con un nerbo citrino: elementi, questi, che conferiscono al vino non solo un'eccellente persistenza, che non stanca mai, ma anche una sensazionale longevità, tale da garantire alle grandi bottiglie di Soave una conservazione più che decennale. Vitigno tardivo, la garganega ha buona acidità e un eccellente equilibrio fra struttura, in genere agile e snella, e morbidezze.
Oltre alla garganega, che si deve annoverare tra le uve bianche più antiche d’Italia, forse di origine greca, nel Soave si coltiva da tempo immemore anche il trebbiano di Soave. Trebbiano di nicchia, dalle rese molto basse, quest’uva è parente stretta del trebbiano di Lugana, e viene utilizzato storicamente in uvaggio con la garganega per produrre un Soave più pronto, leggermente smussato e dai profumi leggibili già in giovane età. Vitigno non facile da allevare, certamente fra i più aristocratici della famiglia dei trebbiano, viene oggi sperimentalmente vinificato anche in purezza. Dopo un certo affinamento sui lieviti, esprime note fruttate di mela e di agrumi dolci come il mandarino. All'assaggio è abbastanza morbido, di bella freschezza, buona struttura e sensibile persistenza.
Le zone del Soave – La zona del Soave può essere identificata con il comparto centro-orientale della Lessinia, sostanzialmente a ovest della rinomata regione della Valpolicella. L’area storica di Soave, nota appunto come Soave Classico, è una serie di colline e valli formate da una trasformazione geologica iniziata oltre 90 milioni di anni fa. L’areale più interessante è quello più densamente vulcanico. Sì, perché non tutto il Soave è vulcanico allo stesso modo: le recenti zonazioni, che hanno portato nel 2019 a inserire nel disciplinare della DOC ben 33 menzioni geografiche aggiuntive (cioè cru tra cui Castelcerino, Carbonare, Froscà, Foscarino, Rugate, Roncà, Fittà, Corte Durlo), hanno infatti dimostrato che ci sono sia aree con suoli prettamente vulcanici, sia prevalentemente calcarei, sia ad esposizione collinare, sia pianeggiante.
I terreni vulcanici compongono una grande porzione della produzione collinare dei vini Soave, e si trovano a tutti gli effetti nel cuore della Lessinia, dove c’era un’intensa attività vulcanica. L’attività ha attraversato tre ere geologiche, interamente in un ambiente marino. Ciò ha dato luogo alla formazione di terreni di colore variabile, dal grigio, al giallo, al rossastro a causa della peculiarità dell’ambiente e dei livelli di ossidazione. Si tratta soprattutto di basalti compatti molto antichi, spesso scuri, ricchi di minerali cui si aggiunge il contesto marino in cui i fenomeni vulcanici hanno avuto origine. Da questa zona, corrispondente alla parte orientale della DOC, provengono i vini più intensi, sfaccettati, strutturati del Soave, e di conseguenza anche più longevi: vini di grande acidità, con note speziate e un finale spesso ammandorlato.
La zona calcarea, che occupa la parte occidentale della DOC, dà naturalmente vini più pronti e meno graffianti in gioventù, con caratteristiche note fruttate, tropicali, agrumate, e in generale un’elevata articolazione aromatica. Ovviamente sussistono anche cru che, magari per la loro estensione come Castelcerino, presentano al tempo stesso rocce basaltiche dure e affioramenti calcarei.
I Monti Lessini
L’ambiente e i suoli – Potrà sembrare una frase fatta, ma il Parco Nazionale dei Monti Lessini racchiude un patrimonio unico di biodiversità. Eppure, questo patrimonio incide in modo decisivo sulla qualità ambientale dei vigneti e, di conseguenza, sull’autenticità e la genuinità dei vini. Pur essendo il territorio caratterizzato da un vissuto geologico piuttosto complesso, nelle zone oggi dedicate alla vite sono predominanti rocce vulcaniche e vulcanico-detritiche basiche: ci troviamo davanti, insomma, ad un terroir vitivinicolo schiettamente vulcanico.
I suoli sono moderatamente profondi, con tessitura fine e con scheletro basaltico scarso in superficie ma più abbondante in profondità, a testimonianza, anche, delle origini oceaniche del territorio. Quarantacinque milioni di anni fa, infatti, bolle di magma in risalita diedero origine a queste strette vallate oggi verdeggianti, sollevandole dal fondo del mare primordiale. Dal punto di vista climatico, poi, le elevate escursioni termiche stagionali e quotidiane esaltano ancor più il potenziale aromatico delle uve.
Per la loro porosità, le terre vulcaniche sono in grado di accumulare acqua e calore solare, rilasciandoli lentamente. Sono inoltre ricche di sostanze nutrienti per la vite e fanno da barriera naturale contro le malattie del suolo. Per queste ragioni la viticoltura su terreni vulcanici richiede minori interventi esterni ed è quindi qualitativamente superiore ed ecologicamente più sostenibile. L’Italia è il Paese vinicolo in cui si trova la maggior varietà di territori vulcanici, eppure quelli storicamente vocati alla viticoltura si contano sulle dita di una mano.
I Monti Lessini sono certamente tra questi, ma i suoli che li caratterizzano sono al tempo stesso abbastanza vario: di diversa identità vulcanica, si potrebbe dire. Alcuni fondovalle, ad esempio, presentano tessiture abbastanza sciolte, con media o scarsa componente calcareo-scheletrica. Tuttavia, circa la metà del comprensorio della Lessinia è occupato effettivamente da ripidi colli basaltici di origine vulcanica, di buona densità acida, che a volte si manifestano sottoforma di tufi neri.
Il risultato dei movimenti vulcanici avvenuti in Lessinia è un mosaico di marne tufacee rosso-violacee, calcari attivi e, come si diceva, scheletro basaltico. Le prime donano al Durello ed al Gambellara – altro comprensorio vulcanico della bassa Lessinia, al confine con il Soave con cui condivide la garganega – struttura e complessità, i secondi conferiscono agli stessi vini dinamismo ed eleganza.
Storia e il vitigno – La viticoltura sui Monti Lessini cominciò con l’arrivo dei Romani, un po’ come in tutta la zona circostante. Anche se è difficile identificare le uve allora allevate, è suggestivo individuare, tra i vitigni citati da Plinio il Vecchio, un tale duràcinus, ovvero “dalla buccia dura”. Un nome che riecheggia l’odierna durella e che sembra tornare nel Medioevo: in documenti locali del 1292 si trova citata una varietà detta “duràsena”, che doveva essere già molto diffusa. Le contrade dei Monti Lessini furono segnate anche dal passaggio dei Cimbri, un popolo germanico che si insediò sui monti del vicentino nel Medioevo, famoso anche per l’arte metallurgica e casearia.
La durella è una varietà a bacca bianca dal grappolo alato e compatto. Il nome deriva dalla durezza o compattezza della buccia e dalla elevata acidità totale che caratterizza il vino, che ne permette un’elevata longevità e ottimi risultati con la spumantizzazione. Queste considerazioni oggi possono essere date per assunte, ma il vitigno, nei decenni passati, ha rischiato l’abbandono, perché pochi viticoltori puntavano su una varietà così ostica da bere in gioventù e – non ultimo – esigente in vigna.
È quindi merito di pochi illuminati proprietari, come Renato Cecchin, se negli anni Settanta si è cominciato a reimpiantare la durella soprattutto nell’ottica, all’epoca pionieristica, di farne una base spumante anziché un bianco macerato dallo stile antico come – anche per limiti tecnologici – si faceva in passato. A Cecchin si deve anche l’invenzione di una gyropalette ante litteram, una sorta di contenitore esagonale per bottiglie in grado di effettuare il rémuage con un semplice gesto: segno, questo, di quanto la spumantistica a metodo classico abbia contribuito al rilancio vitivinicolo della Lessinia.
La durella ama le buone esposizioni ma soprattutto esige nel vigneto un buon ricambio di aria. Eppure la durella garantisce, allo stesso tempo, buona vigoria e produzione costante, anche grazie alle precipitazioni non esigue del Vicentino. Autoctono dei Monti Lessini, la durella è una vite antica e rustica che dona uve dorate la cui caratteristica fondamentale è un tipico sapore acidulo – dovuto proprio all’elevata acidità fissa dell’uva e alla singolare concentrazione di acido malico – e, in caso di macerazione, una tannicità chiaramente percepibile. Graffiante e verticale, è una varietà in questo senso tipica dell’offerta autoctona italiana. E, in particolare, ha tutte le carte in regola – compresa la sapidità, conferita dall’alta componente minerale dei suoli vulcanici – per esibirsi in grandi spumanti a metodo classico anche dopo tantissimi mesi di riposo in bottiglia.
La durella metodo classico si presenta con una spuma fine e persistente e con un colore giallo paglierino più o meno carico, con riflessi verdognoli che, con l’età, evolvono verso il paglierino e il dorato. I profumi sono caratterizzati da sentori di marini di gesso e iodio che sembra esaltare note più floreali di sambuco e biancospino. In bocca è la sua vibrante acidità a definirne il carattere. Ritornano i sentori marini tipici di questo territorio e, anche se il corpo non è mai eccessivo, la sensazione di sapidità nobilitata da un retrogusto minerale e amarognolo non sembra mai esaurirsi. Proprio per queste caratteristiche, ha una grande duttilità, sia come aperitivo che per i piatti più grassi e sapidi.
Disciplinare – Benché i Monti Lessini siano dal Medioevo la patria della durella spumantizzata, il disciplinare della DOC Monti Lessini, istituita nel 1987, contempla diverse tipologie di vino. C’è il rosso, che è un blend di uve internazionali come il merlot, che deve occupare almeno il 50% dell’uvaggio; e c’è il bianco fermo, che prescrive un minimo del 50% di chardonnay. Quanto alla durella, si può imbottigliare come Monti Lessini DOC anche in versione ferma o sottoposta ad appassimento: ne deriva, al caso, un bianco magro ma molto fresco e fragrante, generalmente giovane, e un passito avvolgente ma straordinariamente verticale, tutt’altro che stancante.
La versione oggi considerata più performante e tipica della durella è però la bollicina, tanto che dal 2019 a questa tipologia la legislazione riserva una denominazione a sé stante, chiamata Lessini Durello DOC. Questa denominazione include, con uve durella almeno per l’85% dell’uvaggio (con possibili aggiunte di chardonnay, garganega, pinot bianco e pinot nero), anche spumanti prodotti con metodo charmat: pratica nobile, ma che in zona è assai poco rappresentativa delle potenzialità della durella lungamente lasciata a riposo sui lieviti in bottiglia.
Da disciplinare, per la durella metodo classico sono sufficienti 36 mesi sui lieviti per fregiarsi della menzione “riserva”: tuttavia, i prodotti più sensazionali da punto di vista qualitativo possono raggiungere i 120 mesi di affinamento, con esiti di cremosità, setosità e pastosità che si possono immaginare. Quanto alle tipologie per dosaggio, sono praticate il brut, l’extrabrut e, per gli amanti del dialogo con una durella senza compromessi, nuda e cruda, il pas dosé.
Pur non ancora introdotti a disciplinare, anche nei Monti Lessini è possibile individuare alcuni cru, che sussistono nelle zone a più densa componente vulcanica nei suoli, tra cui spiccano i filari arroccati intorno al monte Calvarina, che danno vini agrumati, eleganti e speziati di grande effetto spumantistico, e verso Agugliana, in pieno Vicentino, che regalano calici di ottima struttura e intensità, ideali anche come vini fermi.
I Colli Euganei
I Colli Euganei regalano alcuni degli scorci più suggestivi di tutta la piana veneta. Infatti, appaiono da lontano come coni rovesciati che si stagliano maestosamente dalla pianura. E, in più, sono stati teatro di passaggi illustri. Ad Arquà, nella parte meridionale del comprensorio, Francesco Petrarca si stabilì per gli ultimi anni della sua vita, dal 1370, in una casa tuttora visitabile nello spettacolare centro storico del borgo. E sui Colli Euganei, qualche secolo più tardi, Ugo Foscolo soggiornò alcuni mesi tra il 1796 e il 1797, respirando il mito di Petrarca e concependo tanti di quei sacri valori civili poi trasposti nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis, che appunto si fingono scritte “da’ Colli Euganei”.
Antichi borghi, ma anche ville patrizie, castelli e castelletti testimoniano questa lunga e aristocratica storia. Che è anche, però, una ancora più antica storia geologica, che racconta tantissimo dei vini di questi colli e della loro grandiosa espressione contemporanea. È d’altronde proprio intorno al Castello di Lispida, a Monticelli di Monselice, che i nobili Corinaldi, proprietari della tenuta e protagonisti della trasformazione in castello di quello che era un antico monastero, verso il 1870 impiantarono viti di uve francesi, merlot e cabernet, di fatto avviando la grande storia dei rossi degli Euganei.
Suoli e climi – Anticamente, la zona dei Colli Euganei era, come tutta la pianura padana, coperta dai mari. Questo finché un susseguirsi di manifestazioni vulcaniche arrivò a scuoterne i fondali. La prima attività eruttiva si manifestò circa 43 milioni di anni fa. Colate sottomarine di lava basaltica, assai fluide e ricche di gas e vapori, si riversarono sul piatto fondale del mare, generando in tempi relativamente rapidi affioramenti e nuove formazioni rocciose. Oggi, ciò che resta di questa prima fase vulcanica affiora nel settore centrale dei Colli.
Ma fu una seconda fase, avvenuta circa 35 milioni di anni fa, che conferì al comprensorio euganeo la sua forma attuale. La forte spinta dei magmi sollevò e fratturò nei modi più disparati gli antichi strati del fondo marino che, fino ad allora, avevano conservato la conformazione originale, ripida e suggestiva. Naturalmente, come in ogni antico comprensorio vulcanico, anche sugli Euganei alcune zone hanno conservato una componente eruttiva più pura e compatta, mentre altre, per effetto degli agenti atmosferici, si sono lentamente sgretolate e mischiate ad altre componenti minerali.
Comprensorio vulcanico nel suo insieme, i Colli Euganei sono quindi molto compositi al loro interno. I suoli più antichi, in realtà, sono di tipo calcareo o, localmente, calcareo-argilloso e marnoso (la cosiddetta “marna euganea”): sono le rocce che un tempo erano fondali marini. Queste rocce sedimentarie si presentano solitamente di color bianco o biancastro, a volte grigio-verdastro, non di rado popolate da fossili marini. Lungo questi sedimenti, diffusi un po’ in tutto l’areale, ha fatto irruzione il primo grande episodio vulcanico di 43 milioni di anni fa. Questa eruzione ha provocato la formazione di rocce basaltiche molto scure, che sono particolarmente concentrate nella zona occidentale e centro-meridionale del comprensorio degli Euganei, soprattutto verso il monte Gemola e il centro di Teolo.
La seconda fase eruttiva ha portato in superficie suoli ad alta concentrazione acida, ricchi in silice, ma di colore variabile dal molto scuro al chiaro. È il caso di formazioni come il monte Cinto, estremo sud-ovest dei Colli, di Rocca Pendice verso Teolo, del monte Brusà presso Luvigliano – nelle vicinanze della storica Villa dei Vescovi, oggi bene del FAI – e naturalmente del monte Cecilia, all’estremità meridionale degli Euganei.
Generalizzando un po’, si può dire che la zona centro-meridionale dei Colli Euganei presenta una maggior concentrazione di suoli vulcanici, pur con occasionali residui dei sedimenti calcarei; è dunque la zona più vocata ai grandi rossi. Nell’areale centro-settentrionale dei Colli, invece, si assiste a una rarefazione dei suoli prettamente vulcanici in favore di una maggiore diversificazione e, fatto da non trascurare, di più frequenti esposizioni settentrionali: è la parte degli Euganei più vocata ai vini bianchi.
A questa ideale disposizione contribuisce anche il clima. Il clima è generalmente più mite rispetto alla pianura, sia in estate che in inverno, con variazioni termiche meno marcate. Così, nei pendii esposti a meridione dove i raggi solari arrivano più diretti e carichi di calore, si trovano molte specie peculiari della flora mediterranea. Diversamente, nei freschi e ombrosi versanti settentrionali e nelle strette incisioni vallive formate da corsi d’acqua per lo più temporanei, si insediano specie amanti di climi freschi, alcune di esse lasciateci in eredità da epoche glaciali lontane.
I vitigni – Come giustamente afferma il Consorzio di Tutela dei vini euganei, sui Colli, in fatto di vitigni, i concetti di autoctono e internazionale si confondono. L’impianto di uve francesi nel comprensorio euganeo risale infatti all’Ottocento, e quindi non è peregrino sostenere che merlot e cabernet sauvignon, ma anche carmenère e cabernet franc, siano, da queste parti, varietà autoctone. Ma andiamo con ordine.
Nella seconda metà dell’Ottocento si avvia sui Colli Euganei un nuovo periodo all’insegna della sperimentazione e della specializzazione. Fu il conte Augusto Corinaldi a mettere a dimora per primo nel Veneto, nella sua tenuta di Lispida, le uve arrivate d’oltralpe, con l’obiettivo di realizzare un’etichetta spendibile all’estero, potenzialmente in grado di vincere anche qualche medaglia internazionale. A tal fine, il conte si dota di uno staff di livello, con enologi di formazione internazionale, e mette su una delle cantine allora più grandi del Veneto, con una capacità produttiva di 30000 ettolitri l’anno.
Il merlot, quindi, diventa il vino più rappresentativo del Padovano già nell’Ottocento, quindi prima della fillossera e prima che scattasse, anche in altre regioni italiane, la moda del vitigno bordolese. La DOC Colli Euganei nasce nel 1969 e accoglie fin da subito le varietà internazionali come le più tipiche del territorio. Saggia decisione, perché gli Euganei conferiscono a merlot e cabernet un taglio tutto particolare, proprio, singolare: i Colli sono il più importante, forse unico comprensorio del Vecchio Mondo in cui i vitigni bordolesi prosperano su un suolo vulcanico, a tratti calcareo, aggiungendo un’insolita mineralità alle loro caratteristiche note erbacee.
A questo si devono sommare le consistenti variazioni microclimatiche e microterritoriali che contraddistinguono i Colli, nonché le diverse esposizioni e, ovviamente, le varie tecniche di vinificazione e affinamento. Come si diceva, nella zona nord dei Colli prevalgono, oltre ai bianchi, rossi carnosi, giovani e fruttati, che nelle versioni affinate esprimono setosità e suadenza aromatica. Verso sud, i rossi assumono un profilo più austero, quasi sempre vocato all’affinamento in legno, sia in botte grande, sia in barrique – fatto più che autorizzato dall’ispirazione bordolese di molti di questi assemblaggi. La matrice vulcanica dei suoli consegna vini complessi ed eleganti, quella calcarea gioca su struttura e alcolicità.
I vini – Il Colli Euganei rosso – “riserva” dopo almeno due anni di sosta in cantina – è spesso prodotto con una prevalenza di merlot e un saldo abbondante di cabernet sauvignon. Non di rado concorrono altre varietà, anche autoctone, come il raboso e la barbera, che sono uve storiche della zona. La prevalenza di merlot, da ritenersi classica, conferisce a questi vini un tannino avvolgente, mentre il cabernet interviene con complessità aromatica ed eleganza di struttura. A seconda della tipologia del recipiente di affinamento, questi vini assumono naturalmente note tostate, speziate e vanigliate, esprimendosi benissimo anche oltre vent’anni dopo la vendemmia. Il loro corredo di durezze, infatti, non si limita alla tannicità tipica delle uve, ma include la sapidità e la freschezza caratteristiche del terroir vulcanico.
Il disciplinare di produzione, inoltre, consente di sperimentare il Colli Euganei rosso da monovitigno. Ed è una scelta vincente, perché da queste parti il merlot e il cabernet si esprimono con una personalità unica anche in purezza, tanto che alcune aziende hanno fatto di questi prodotti le punte di diamante della loro gamma, spesso riservando loro affinamenti in botte (vuoi grande, barrique o tonneau) superiori ai tre anni. I rossi giovani si accompagnano a risotti ricchi, primi piatti di carne (come il classico pasticcio o i bigoli al ragù d’anatra o di cinghiale), o con secondi di carni bianche “in tocio”, cioè in umido. I rossi delle annate precedenti affinati in legno, sono ottimi con tutte le carni rosse, dalle preparazioni alla griglia a quelle brasate e formaggi stagionati.
Quanto ai bianchi, i Colli Euganei regalano soprattutto, sul fronte degli autoctoni, vini immediati e di piacevole beva. C’è il serprino, che è un biotipo lontano parente della glera, cioè il vitigno del prosecco, e che dà un bianco leggero e frizzante con chiari sentori di piccoli fiori bianchi. Poi c’è il pinello, autoctono sopravvissuto grazie alla passione di pochi vignaioli; alquanto esigente in vinificazione, concede un calice giovane, leggero, simpatico, ricco di profumi di frutta bianca freschissima. Grandi risultati dà sui Colli Euganei il manzoni bianco, ricco, complesso e sfaccettato, con note olfattive di peperone, erbe aromatiche e iodio e, al sorso, una sorprendente struttura, che si rivela vocata all’evoluzione.
L’uva bianca forse più rappresentativa dei Colli Euganei è oggi il moscato giallo, che, per le sue particolari note agrumate, viene chiamato da queste parti moscato fior d’arancio. Titolare dal 2011 della esclusiva DOCG Colli Euganei Fior d’Arancio, è tipicamente prodotto in versione spumante dolce. Complice l’alta acidità e mineralità dei suoli, è un ottimo vino da dessert ma anche da aperitivo, con una potente freschezza che ben ne bilancia la mai stucchevole dolcezza. Esprime sentori mediterranei, aromi citrini, di zagara, di salvia e di albicocca presenta una gradazione alcolica bassa, intorno ai 6 gradi, che invita a berne un secondo bicchiere.
Si produce anche in versione passita (allo scopo gli sono riservati locali idonei adeguatamente aerati, in cui le uve vengono sdraiate per qualche settimana) o da vendemmia tardiva. In questa veste si manifesta in modi molto diversi a seconda della concentrazione delle uve e della tecnica di affinamento, che avviene, a seconda del produttore, in legno o in solo acciaio. Nel primo caso è ampio, etereo, vellutato, speziato, mentre nel primo caso conserva in modo più leggibile la pizzicante nota agrumata della varietà.